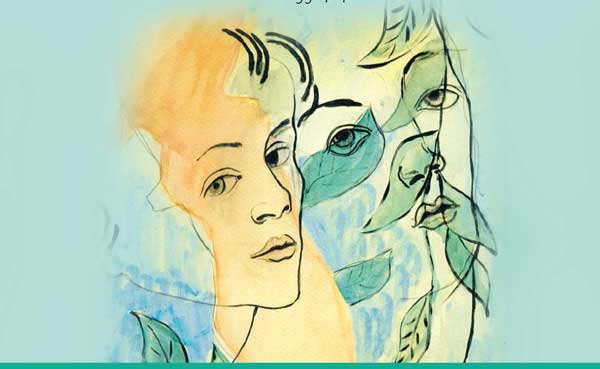James Hillman non è certo un autore che, nel mondo psicoanalitico o affine, sia passato inosservato e la sua opera non abbia suscitato discussioni e dibattiti accesi, suscitando consensi e stroncature, non sempre sulla base di valutazioni obiettive dei dati.
Si tratta di un autore certamente molto pubblicato in Italia sia attraverso la traduzione dei suoi numerosi libri, sia con la pubblicazione di interviste generosamente concesse a vari tipi di media, sino ad arrivare quasi aduna invasione di mercato.
Un autore che comunque non lascia indifferente o disturba e non solamente per i contenuti molto (troppo?) estesi dei suoi interessi anche in ambiti di competenza che parecchi gli ritengono estranei.
Ma l’opera di Hillman e le reazioni alla stessa ci sembrano idonee ad entrare nella tematica del 23° Congresso SIMP ed alla sua tematica centrata sul pregiudizio nella terapia ed è proprio a questo proposito che abbiamo voluto riproporre alcuni interventi, apparsi in tempi diversi, comunque remoti, su quotidiani relativi alla pubblicazione di differenti lavori di questo autore.
Si tratta di interventi da parte di professionisti e studiosi di impostazione differente: junghiana (A. Romano), freudiana (E. Funari), studioso delle religioni (E. Zolla) con toni e da prospettive differenti si esprimono, criticamente, su Hillman e sulla validità della sua opera.
È proprio leggendo questi diversi interventi che ciascuno potrà cercare di orientarsi sull’incerto confine che separa la critica motivata dal pregiudizio ideologico.
Nota:
dalla lettura del programma relativo al prossimo Congresso SIMP si nota come spesso ricorrano termini quali “immagine” – “immaginazione” – “immaginale” – “immaginario”, argomenti che spesso sono oggetto di valutazioni variamente pregiudiziali in senso positivo o negativo e su cui sarebbe interessante ricevere opinioni da parte sia dei soci SIMP sia di altri studiosi.
Un altro aspetto delle tesi di Hillman, psicologo postmoderno
Una discutibile tesi di James Hillman
Le polemiche suscitate dal neojunghiano americano
Un altro aspetto delle tesi di Hillman, psicologo postmoderno
Gli dei e l’inconscio guidano il gioco della vita.
“Il vivere psicologico significa vivere in una fantasia, in una storia, essere raccontati da un mito”.
James Hillman, junghiano dissidente la cui fama – come dimostrano le sempre più frequenti traduzioni dei suoi scritti e le polemiche che essi suscitano si va curiosamente espandendo ben oltre gli ambienti psicanalitici, suggerisce in “Re-visione della psicologia” il rifiuto radicale sia di ogni teoria della psiche intesa come una struttura che tende ad una possibile (e sempre minacciata) unità, sia della prassi terapeutica che a quella teoria si ispira.
I suoi bersagli polemici sono essenzialmente due: l’immagine dell’Io “eroico”coltivato dalla tradizione occidentale e l’idea di svl1uppo.
Entrambi questi modelli sarebbero espressione di un monoteismo psicologico, contro cui Hillman rivendica una esigenza politeistica, un policentrismo psichico, una frammentazione dell’esperienza il cui senso va ricercato nel puro fatto del suo esistere.
Ciò che esiste infatti esprime sempre una esigenza legittima in quanto rinvia a un dio, a una immagine archetipica, a un mito che in quel momento si fa presente ed esige di essere contemplato, amato, assunto come guida.
Compito dell’uomo è allora trovare, per ogni evento, conflitto, afflizione, la persona mitica che ne è il sostegno e il fondamento.
Gli dei ci parlano, e la stessa patologia è uno “stile di linguaggio” con cui la psiche parla a se stessa.
L’unica e fondamentale domanda che l’uomo psicologico deve porsi è quindi: a quale persona della psiche appartiene ciò che mi sta accadendo, in quale mito si colloca?
La nostra vita è l’attuazione di scenari mitici, e la psicologia non può essere altro che un esercizio dell’immaginazione, un continuo andare al di là dell’evento nella sua concretezza per contemplare lo scenario mitico su cui esso si accampa.
Il libro, e l’intervista che ne è il completamento, sono certo affascinanti per la ricchezza e varietà dei riferimenti culturali e soprattutto per lo stile fervido e accattivante.
E’ uno stile in cui l’intonazione profetico-missionaria si coniuga con sprezzature e civetterie squisitamente letterarie, quasi a mimare, all’interno della scrittura, la tesi fondamentale per cui il comportamento mitologico consiste nell’agire all’interno della retorica di un certo stile».
E tuttavia Hillman convince nei particolari ma non nella sostanza.
La psicologia che egli delinea si configura come una sorta di psicologia estetica: la vita è spettacolo, e sia pure spettacolo divino;
l’esistenza umana è il risultato di un gioco delle potenze inconsce che la governano; all’uomo spetta riconoscere queste potenze e amarle cosi come si ama la necessità.
Questa radicale “demitizzazione”lascia fuori il tanto maltrattato Io, quello che non solo vuole contemplare ma anche comprendere e integrare in un progetto le forze da cui pure è agito.
Messa da parte ogni esigenza di unità (lo junghiano Sé), rimosso il tema della iniziazione come prova, superamento e sviluppo (pur cosi presente nei miti), viene a cadere ogni tensione. ogni problema etico, ogni reale confronto tra l’io e l’inconscio e resta un compiacimento estetizzante della disgregazione.
Al tradizionale imperialismo dell’Io si sostituisce: l’onnivoro prevalere delle potenze incon-sce.
Lo spazio psichico viene occupato da una comunità anarchica: e qui Hillman rivela una certa consonanza con le tendenze che oggi vengono dette “postmoderne”, nel senso dell’eclettismo irresponsabile e della giustapposizione giocosa (ma spesso futile) di stili contrastanti. (Augusto Romano)
James HilIman (1983): “Re-visione della psicologia”, Adelphi, 451 pagine.
James Hillman (1983): “Intervista su amore anima e psiche”, Laterza, 159 pagine.
Una discutibile tesi di James Hillman
C’è modo e modo di immaginare.
In “Vana fuga dagli dei”, uscito da Adelphi, James Hillman espone concetti che mi lasciano perplesso.
Insiste a dire che gli archetipi sono e debbono essere infermi e che se li vogliamo imitare dobbiamo rifarne i tratti morbosi.
Dubito che sia del tutto corretto parlare di un’imitazione di archetipi, ma è certo stravagante
volerne ricalcare le infermità.
Credo che le tesi di Hillman nascano dal rifiuto di abbandonare la suddivisione in buono e cattivo quando parla di archetipi, ma è proprio scartando quella scissione che si giunge a vedere un archetipo.
Così Hillman nega che esista una differenza tra rivelazione e delirio.
Di colpo la distesa delle follie più misere prende aspetti rivelativi, ma alla fine la confusione travolge ogni ordine.
Si coglie alla radice l’errore di Hillman osservando come egli si atteggia dinanzi a un vocabolo straordinariamente sensibile, dal significato tremendamente arduo, immaginale.
Si può rifiutare, ignorare, ma se si accoglie, bisogna distinguerlo nitidamente da immaginario.
Hillman dichiara invece che l’immaginazione più oscena e convulsa è la prima materia ideale dell’immaginabile, che il macabro ed il sofferente:dipanano un immaginario preziosissimo, anzi un immaginaIe perfetto, che proprio da dove si è caduti lunghi e distesi occorre partire per intrqdursi nell’immaginale.
Ma se il punto di caduta, l’orrore in cui si sia scivolati è ciò che va, curato e sostituito con una visione terapeutica, immaginale, il primo è il punto di partenza, mentre la seconda è il termine d’ogni terapia o avventura psichica felice.
Contro questa evidenza Hillman si ribella, rifiuta il concetto di immaginale, che Henry Corbin qualificava come “ieratico, serio, grave, stilizzato e pregnante di senso”.
Hillman si ostina a usare il vocabolo, ma ne nega il significato, lo confonde con l’immaginario malato e caotico.
Certo, così facendo ottiene qualche barbaglio seducente, ma abusa del vocabolario.
Se la purificazione, il passaggio dal malato al sano, è impossibile, usare la parola immaginale è una truffa.
Essa comparve nella tarda latinità, usata dai neoplatonici per designare l’immaginario esemplare, paradigmatico, archetipico.
In seguito il suo significato non fu quasi più evocato fino a quando Coleridge lo riaffermò distinguendo l’immaginale (imagination) dal fantasticante (fancy).
Ma molti credettero che parlasse a vanvera e lo dileggiarono apertamente.
Fu merito singolare di Henry Corbin riesumare la vecchia parola per tradurre l’alam al mithal dei suoi filosofi arabi o persiani (o l’olam hademuth dei cabbalisti).
Corbin cominciòa individuare il concetto di immaginale negli scritti di Ibn’ Arabi, per il “quale ogni realtà è priva di sostanza se non diventa simbolo del divino.
Ma soggiungeva che l’immaginazione creatrice immagina il Creatore, la cui creazione è assoluta immaginazione, sicché l’immaginazione umana è “un’energia rispondente al bisogno creatore, alla stessa creatività”.
A molti questa aggiunta parve un’eresia.
Ibn’Arabi teorizzò un piano immaginale indipendente dall’immaginante, e su di esso ritenne che lampeggiassero i simboli del divino, sicché il bel giovane che come tale appariva ai compagni di Maometto, a Maometto si svelava per l’arcangelo Gabriele.
Corbin passò quindi allo studio di Sohrawardi, nel quale lo zoroastrismo e l’Islam si componevano in uno.
Per lui l’unica vera filosofia era quella del perfetto saggio che riuniva la conoscenza filosofica e l’esperienza mistica modellata sul viaggio di Maometto dalla pietra del Tempio di Gerusalemme fino all’apice dei cieli.
Ogni settore del cosmo va proiettato sciamanicamente sul piano immaginale, che forma un intermondo fra l’intelligibile ed il sensibile.
Alla sua ricognizione di tutta la filosofia sufi, Corbin si appellava per precisare che cosa fosse l’immaginale.
Soltanto Pavel Florenskji nel nostro secolo ne aveva colto l’essenza, illustrandola come presente nell’iconostasi delle chiese d’Oriente, dove la icone servono come finestre sull’invisibile, simboli esemplari.
È sicuro Hillman che gli convenga usare questo,vocabolo immaginale?
È davvero certo di averne esperienza?
È ossessionato dal bisogno di impasticciare in un unico groviglio le fantasticherie più grottesche e scomposte e dolorose con l’immaginale, ma poi parla dell’immaginale come fine verso il quale la terapia si protende!
Jung mostrò una quantità di quadri di pazienti dove le figure più perfette dell’immaginale, i quadri tipici della pittura sacra di ogni tradizione (cerchi che si moltiplicano e si evolvono verso uncentro, intersecarsi di poligoni che in armonia puntano alla propria origine) appaiono in modi ora confusi ora più vicini ai modelli.
Ma è soltanto enunciando con chiarezza rigorosa le figure perfette che si potrà indicare il fine della terapia, non aggrovigliando all’infinito gli sgorbi e gli incerti cenni dei malati.
Perché Hillman ritiene che soltanto confusione e sofferenza abbiano realtà?
Se vorrà incamminarsi fuori del dolente ginepraio, sarà suo fine necessario dipingere con nitore e definire con chiarezza l’immaginale puro, specie in un’epoca nella quale le icone canoniche ed i mandala consacrati paiono scomparire.
Elémire Zolla
Le polemiche suscitate dal neojunghiano americano
Povero Hillman, senza capo né coda.
Ieri Masson, oggi Hillman: ogni tanto spunta da qualche parte un grande accusatore della psicoanalisi, un fiero annunciatore della sua fine, in nome di non si sa bene quale nuova verità acquisita, se non quella promossa da uno sfrenato protagonismo e da un vacillante impianto culturale e scientifico.
Masson volava basso: credendo di avere individuato vizi innominabili nella vita privata del giovane Freud, giungeva alla conclusione che tutta la dottrina psicoanalitica ne risultava inficiata.
Hillman, no: preferisce le alte vette di un frasario vuoto che, con la collusione del cronista di turno, si ammanta, seduttivamente ed in termini asseverativi, di un discorso etico-scientifico, privo di un individuabile costrutto.
Se fosse vera l’annotazione di Hillman che la psicoanalisi ha “cercato di annodare il muso alla coda del cane”, il pensiero dello stesso Hillman non correrebbe quindi lo stesso pericolo, essendo privo di capo e di coda.
Ma quali sono le argomentazioni addotte dallo psicologo analitico junghiano, alle quali mi riferisco (vedi «Corriere» di venerdì 4 novembre)?
Vediamo.
La psicoanalisi sarebbe diventata il nostro secondino (sic!) e avrebbe popolato la nostra coscienza – attenzione! – e addirittura il nostro inconscio di tabù invincibili.
Esisterebbe oramai un diffusissimo vizio della soggettività che verrebbe ad alterare i nostri rapporti con le cose.
Naturalmente tutto questo sarebbe opera della psicoanalisi, strana operazione di un pensiero grandioso che fa della stessa psicoanalisi, intesa come disciplina, il volano di ogni accadimento politico e sociale nel mondo intero!
Ritengo che il lettore, ignaro di tutte queste nefandezze perpetrate a sua insaputa, a questo punto potrebbe avvertire un certo timore per la sua esistenza quotidiana.
Vorrei tranquillizzarlo: la psicoanalisi è una disciplina sorta un centinaio di anni fa, che, come tutte le discipline scientifiche, cerca ancora e sempre la propria identità e approfondimento dei propri strumenti tecnici e teorici, nell’indagine e nel lavoro che migliaia di operatori svolgono in tutto il mondo.
Come tutti gli ambienti scientifici risente di conflitti, promuove accesi dibattiti, si sviluppa in posizioni interne richiedendo un continuo confronto: aspetti, questi, che tuttavia devono essere affrontati in termini di verifica, di scambio, in comunicazioni articolate ed estensibili.
Sarebbe lungo e fuori luogo illustrare qui il cammino compiuto dalla psicoanalisi, dalle sue origini ad oggi, per proporne il senso, la natura e la funzione.
Ma rimane il fatto che è nella documentazione seria e nell’approfondimento dello studio che alloggia per ciascuno di noi la possibilità di riconoscersi, di dissentire o di modulare i propri interessi o le proprie perplessità a fronte della disciplina psicoanalitica.
Non si può più farsi bloccare (e questo vale per ogni campo del sapere) dal “j’accuse” dei vari enfants térribles (così è stato definito in un altro articolo Hillman) che si presentano improvvisamente sulla scena: ormai l’età ce l’hanno, che se ne, rendano conto. (Enzo Funari).